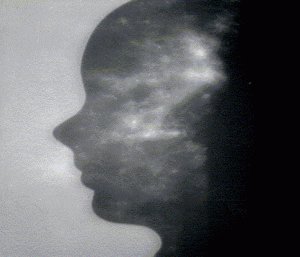Eugenio Borgna e il linguaggio delle solitudini
Una “fotografia” dell’animo umano (recensione)
G. Regnani, s.t., 1991
Emily Dickinson, a proposito della solitudine, ha scritto una frase illuminante, che ben descrive lo stato di quanti vivono una condizione di isolamento (quale che sia la natura della loro solitudine, aggiungo):
“Forse sarei più sola senza la mia solitudine.”
Con queste parole illuminanti Eugenio Borgna inizia il suo cammino verso il linguaggio delle solitudini. Un’esplorazione e un’analisi che ha condensato nel saggio intitolato “La solitudine dell’anima”, pubblicato da Feltrinelli nel 2011.
Eugenio Borgna è stato libero docente alla “Clinica delle malattie nervose e mentali” dell’Università degli Studi di Milano ed è primario emerito di psichiatria dell’Ospedale Maggiore di Novara. Autore di testi specialistici e di saggi divulgativi, è divenuto un esponente della psichiatria fenomenologica, contestando l’interpretazione naturalistica delle patologie mentali che ricerca le cause della psicosi nel malfunzionamento dei centri cerebrali e la sua cura attraverso interventi biologici. Un orientamento che, piuttosto, pone particolare attenzione alla comunicazione con il paziente, improntandola su modelli capaci di favorire l’immedesimazione, l’ascolto e la partecipazione emotiva, per una migliore comprensione del vissuto della persona interessata. Un impegno, il suo, per una “psichiatria gentile” – nei casi in cui questo orientamento risulti applicabile e considerando l’inevitabilità di possibili sconfinamenti – basata prioritariamente e principalmente su un’idea di cura che miri ad orizzonti più vasti, camaleontici, umani. Un’idea di cura più ampia, quindi, che non sia solo il frutto un’ideologia tecnologica. Una dimensione curativa meno “fredda”, dunque, che non inondi il paziente interessato di indagini sempre più sofisticate, alienanti, esasperate ed assolutizzate. Una visione della professione nella quale non si dimentichi mai che, in definitiva, il paziente è una persona fragile che convive, suo malgrado, con una malattia. Una malattia che, di norma, contribuisce non poco ad accrescere e ad ampliare ulteriormente, tra l’altro, proprio la fragilità dell’esistenza, già particolarmente provata, del malato. Un percorso terapeutico più forte sotto il profilo dialogico, quindi, che non si fondi solo su alleati tecnologici, ma, imprescindibilmente, sul contributo strategico e trasversale della parola. Un elemento “terapeutico” indispensabile, il dialogo, che favorisca un’interrelazione più autentica, più profonda, fatta talvolta anche solo di sguardi e, non ultimo, di silenzi. Non solo tecnologia assolutizzante e terapie farmacologiche, quindi. La ragione, precisa l’autore, è insita nel fatto che in psichiatria la tecnologia, da sola, non è ancora in grado di formulare in modo puntuale una diagnosi e il relativo, conseguente, percorso di cura. In psichiatria, ha precisato ancora Eugenio Borgna, sono ancora e fondamentalmente le parole del paziente che, se ben ascoltate, possono aiutare il medico curante a fare una buona diagnosi che inquadri, per quanto possibile, correttamente la natura e l’origine dei disturbi che affliggono la persona di volta in volta interessata.
Ma la ricerca di un dialogo più umano, che tenti di (ri)alimentare la luce della speranza, prima ancora che nel paziente, proprio nell’anima del medico curante, è fondamentale per non correre il rischio di vanificare (in parte o, addirittura, del tutto) anche l’impiego delle più sofisticate strategie terapeutiche.
Sul valore/funzione cruciale della speranza, Eugenio Borgna, ha citato Walter Benjamin, che, al riguardo, ha affermato lapidario:
“Solo per chi non ha più speranza ci è data la speranza.”
Una sintesi illuminante, che ha ulteriormente definito, aggiungendo:
“L’ultima speranza non è mai tale per chi la nutre, ma solo per quelli per cui è nutrita.”
E ricollegandosi nuovamente ad Emily Dickinson, Eugenio Borgna ha evidenziato che le parole del silenzio e della speranza possono diventare una sorta di medicina in grado di curare chi soffre. Ma, ha precisato, sono più inclini ad esercitare al meglio questo “strumento” coloro che hanno eventualmente fatto esperienza – talora in forme anche indicibili – della sofferenza. In caso contrario, può risultare difficile che le loro parole siano capaci di oltrepassare i muri innalzati dal dolore e dalla solitudine di un’anima ferita. Al riguardo, l’autore ha richiamato nuovamente in causa Emily Dickinson, che ha ben sintetizzato quale dovrebbe essere la vera “qualità” di chi volesse tentare utilmente di varcare questi tristi confini:
“Ad un cuore spezzato nessun cuore si volga se non quello che ha l’arduo privilegio d’avere altrettanto sofferto.”
Pertanto, solo la conoscenza acquisita con l’esperienza sulla propria pelle, con la percezione diretta del dolore fisico e/o dell’anima, potrebbe eventualmente favorire davvero la sintonia con un altro cuore straziato ed essergli eventualmente di aiuto.
Una sintonia ed un’immedesimazione con l’altro da sé tutt’altro che facile, ha sottolineato l’autore, ricordando quanto ha pragmaticamente scritto Giacomo Leopardi pensando a chi ha perduto la propria speranza di essere felice:
“Chi ha perduto la speranza d’essere felice, non può pensare alla felicità degli altri, perché l’uomo non può cercarla che per rispetto alla propria. Non può dunque neppure interessarsi dell’altrui infelicità.”
La costruzione graduale di un rapporto non meramente formale, asimmetrico, astratto, ma vero e vitale, per Eugenio Borgna, è quindi fondamentale affinché il paziente, piuttosto che giudicato, oggettivizzato, si senta, invece, ascoltato ed accettato con la sua specifica interiorità, comprese le sue debolezze. Libero, dunque, di manifestare la propria soggettività. Una libertà, in ogni caso, già più o meno minata e assediata dalla malattia e dalla solitudine che, a seconda dei casi, ne è la causa e/o l’espressione. E una psichiatria gentile – intesa da Eugenio Borgna come una scienza distante dall’assolutizzazione naturalistica – può certamente rapportarsi anche con esperienze psicopatologiche, oltre che umane, caratterizzate da una dimensione di sofferenza e di dolore dell’anima. Non il (solo) dolore del corpo, quindi. Non solo il dolore somatico, per quanto la (con)fusione con il dolore dell’anima non solo sia sempre possibile, quanto, sovente, non proprio inevitabile. Una convivenza tra il dolore interiore e quello del corpo che non esclude pregiudizialmente, ha evidenziato l’autore, anche l’eventualità di integrare la terapia con trattamenti di tipo farmacologico.
Sempre riguardo alla possibile commistione tra dolore fisico e spirituale, Eugenio Borgna ha poi riportato anche le riflessioni del giornalista polacco Ryszard Kapuściński, che, in uno dei suoi reportage, scriveva:
“Dolore e sofferenza. Il dolore fa parte della sofferenza tormenta tutto il nostro essere, ci logora, ci indebolisce e spesso ci degrada. Il dolore è qualcosa che trattiamo come un male naturale, ammissibile, evidente: se una sega ci taglia un dito, è logico che la mano ci faccia male e non ci vediamo nulla di strano. Al dolore si perdona. Non così alla sofferenza. La sofferenza ci appare un’ingiustizia, una disgrazia, un torto immeritato: la nostra prima reazione alla sofferenza è di ribellione, di protesta. La sofferenza ci offende, anzi ci degrada.”
Nella solitudine il dolore e la sofferenza confluiscono in maniere diversa, talora contrapponendosi e/o affiancandosi tra di loro, nello scorrere dell’esistenza caotica della nostra epoca. E l’analisi di Eugenio Borgna, con sguardi ed analisi a più dimensioni, è dedicata proprio alle diverse forme della solitudine che emergono nel quotidiano stordente dei nostri giorni. Una solitudine variegata, inghiottita dalla dimensione mondana di ciascuno di noi, all’inseguimento di mete ideali e fantasmiche. Una ricerca (sublimata) che Eugenio Borgna, nella sua analisi dei linguaggi della solitudine, ha definito emblematicamente: “stelle filanti”. Una solitudine, ha precisato l’autore, che, a seconda dei casi, è sempre segnata da uno specifico grado di relazione tra la persona interessata e gli altri. E i confini di uno stato di solitudine non sono mai del tutto netti. Ciò premesso, Eugenio Borgna ne ha comunque delineato due macro aree, distinguendo, da una parte, una solitudine interiore – positiva, potrei forse aggiungere – che di norma è una sorgente creatrice e, dall’altra, una solitudine dolorosa, negativa, che è una fonte di sofferenza e di isolamento. Nella prima delle due dimensioni, ha aggiunto Eugenio Borgna, la solitudine emerge sulla scorta di un portato variabile di sentimenti legati al passato della persona interessata, fatto di istanze diverse, in un misto di riflessioni, di serenità e, non ultime, di speranze. Nella seconda, l’isolamento che predomina si nutre di più forme di sofferenza, quali: la malattia, il dolore, l’indigenza materiale e/o spirituale e, non ultima, la dissoluzione di sogni e/o di rapporti umani. Sentimenti fondati su di uno scollamento in qualche misura volontario da cose e persone, che avviene per ragioni diverse, ma, di norma, prevalentemente individuali. Un mondo di sensazioni che si alimenta e ruota sulla mancanza di interesse per chiunque e per qualunque cosa al di fuori di sé. In altri termini, secondo l’autore, la solitudine creatrice, rispetto alla solitudine e/o all’isolamento negativo, può essere considerata come il silenzio contrapposto al mutismo. Nel primo caso, la persona interessata, nonostante viva nel silenzio, non è detto che non abbia e/o non voglia dire qualcosa agli altri. Il mutismo, all’opposto, è invece caratterizzato dall’impossibilità di un qualsivoglia dialogo con gli altri. Nel primo caso, quindi, si continua ad essere significativamente aperti in vario modo agli altri, alla vita, alla trascendenza, mentre, nel secondo caso, la solitudine negativa rapisce e imprigiona la persona interessata, condannandola ad una forma di isolamento e di chiusura dal/verso il mondo.
Nel caso dell’isolamento doloroso, ha aggiunto inoltre Eugenio Borgna, l’interessato è immerso in un orizzonte divorato dall’indifferenza e dall’incomunicabilità, divenendo un’entità solitaria chiusa in un suo perimetro di afflizioni, come una casa priva di porte e di finestre. La persona che vive una simile forma di solitudine-isolamento non vuole o non può uscire da questa sua prigionia che non gli consente di condividere una comunità di destino con il resto del mondo.
Per queste persone può non esistere più un domani e può morire qualsiasi speranza.
Un particolare interesse di Eugenio Borgna è dedicato proprio a questo tipo di solitudini che (ri)emergano da vite segnate dal dolore fisico e spirituale. Un dolore talvolta silenzioso che intacca, come accennato, anche i rapporti interpersonali. Le relazioni sociali, la rete di legami preesistente si altera, dunque, e porta il protagonista a chiudersi in un recinto di solitudine-isolamento che, all’opposto di quella creatrice, è un confinamento fragile, indifeso, doloroso.
Dolore fisico, da una parte, che apre le porte a forme di isolamento talora estreme. Dolore spirituale, dall’altra, che nasce dalla depressione e reclude l’anima interessata in un’insostenibile e straziante solitudine interiore, segnata da confini talvolta invalicabili, con inevitabili conseguenze, quali la rarefazione e/o persino la scomparsa della comunicazione con gli altri.
Tuttavia, si può talvolta anche uscire da questo stato di isolamento – causato, ad esempio dalla malattia, dalla depressione o dalla perdita di importanti relazioni sociali – allorché si riesca a trasformarlo in una forma solitudine creatrice che si fondi su contenuti emozionali positivi. Al riguardo, Eugenio Borgna, ha evidenziato che non è tanto temibile l’isolamento causato dalla malattia quanto quello causato dal deserto delle emozioni. Una desertificazione emotiva, quest’ultima, particolarmente temibile, perché può essere strisciante, camaleontica, dissimulante, arida e, non ultimo, talvolta celata nel fondo dell’anima. Non è affatto facile, ha inoltre aggiunto l’autore, scorgere le tracce, talora pressoché impercettibili, della solitudine-isolamento anche in persone che ci sono familiari, che, al di là delle apparenze, sono precipitate, loro malgrado, nella fragile ed insidiosa palude di una solitudine dolorosa e segreta.
Quando la sofferenza entra nell’anima, straziando le fibre più intime dell’interessato, uno dei più significativi effetti collaterali, ha ribadito l’autore, è la tendenza a creare un confine, una distanza, in qualche caso incolmabile, dal mondo delle persone e delle cose, isolando il protagonista e incrinandone, in vario modo, le sue relazioni con gli altri. Il senso della sofferenza non è semplice da individuare e comprendere: un ulteriore conferma della complessità e della fragilità umana, talora percettibile, talaltra no. Eugenio Borgna nel libro ha citato anche Xavier Thévenot, ucciso dal Morbo di Parkinson, che, in proposito, scriveva:
“Chi mi può incontrare nella mia sofferenza? Tutte le parole che mi sono rivolte risuonano più o meno false. È qualcosa che va al di là delle parole, dei linguaggi. Mi sento solo. Chi è in grado di capire ciò che c’è di unico nel mio dramma interiore, nella mia prova fisica, psichica? Conosco allora la tentazione di rinchiudermi in questa solitudine. Eppure, nello stesso tempo, una parte di me vorrebbe comunicare. Sono lacerato tra questi due desideri, tirato da una parte all’altra. Quando è molto forte, la sofferenza ci sembra stupida e assurda, come dicono i filosofi”.
È dando ancora voce a Xavier Thévenot, l’autore, riportandone parole intrise di amaro dolore, nostalgia e sgomento (perché ormai in fin di vita), ha scritto:
“Proprio quello che mi procurava la gioia di vivere, il corpo, la famiglia, i figli, la fede cristiana, oggi mi disorienta. Crollano ora tutte quelle certezze facili che sorreggono la fede e l’amore. A chi o a cosa rivolgermi per rimettermi in piedi? È lo smarrimento! Se sono cristiano, cerco di trovare il senso di quello che mi succede. Ascolto quello che si dice della sofferenza intorno a me. In particolare, coloro che stanno bene, i quali qualche volta diventano per me quasi un insulto, perché scoppiano di salute, di gioia di vivere. Ci sono persone che hanno sempre pronte spiegazioni della sofferenza. I teologi, i preti, gli amici pieni di buone intenzioni che non esauriscono mai i discorsi e le belle teorie. Li ascolto con onestà ma per lo più sento solo chiacchiere prive di equilibrio”.
Di fronte a queste riflessioni divengono immediatamente fragili e inutili tutte le cose dette da medici, religiosi, scrittori e filosofi che si confrontino con la sofferenza e la solitudine. Alla persona che soffre, ma non solo, possono talora sembrare dei naufraghi disperati. Naufraghi che nuotano, senza la certezza di un approdo sicuro, talora proprio nel deserto delle loro stesse parole, in qualche caso persino astratte, ridondanti, disincarnate di fronte alla malattia e alla relativa solitudine che di norma ne deriva. Sono parole che, in ogni caso, ci avvicinano comunque in qualche maniera al mistero e alla solitudine del dolore del corpo e dell’anima che incombe sull’esistenza. Sono parole, inoltre, che, nella loro asciutta consapevolezza, descrivono a loro modo la dimensione umana e psicologica, esistenziale e metafisica di chi soffre. Parole che, in qualche caso, arrivano persino a non temere il passare del tempo e, divenendo inossidabili, resistono all’oblio e ad eventuali tentativi di rimozione. Confermano che non esiste, per quanto ovvio, una sola sofferenza, ma che ognuno di noi ha un suo modo (unico) di vivere, e, quando arriva il “proprio turno”, un modo (altrettanto unico) di subire e convivere con la sofferenza.
Una condizione peculiare che ha descritto attraverso queste riflessioni di Virginia Woolf:
“Con la malattia la simulazione cessa. Appena ci comandano il letto, o sprofondati tra i cuscini in poltrona alziamo i piedi neanche un pollice da terra, smettiamo di essere soldati nell’esercito degli eletti; diventiamo disertori. Loro marciano in battaglia. Noi galleggiamo tra i rami nella corrente; volteggiando alla rinfusa con le foglie morte sul prato, non più responsabili, non più interessati, capaci forse per la prima volta dopo anni di guardarci intorno, o in alto – di guardare, ad esempio il cielo”.
La condizione molteplice di uno stato patologico comprende, tra le altre, anche le fasi acute e croniche della malattia. Due distinti stadi che, conseguentemente, condizionano differentemente i modi di essere e di vivere degli ammalati. Eugenio Borgna li ha efficacemente descritti in questi termini:
“L’acuto e il cronico hanno a che fare con una diversa esperienza del tempo: del tempo obiettivo, del tempo dell’orologio, e del tempo soggettivo, del tempo interiore. La malattia acuta è divorata dal presente, quella cronica dal futuro: con le conseguenti diverse risonanze emozionali, e nel vortice di una ininterrotta diversa articolazione fra l’una e l’altra forma temporale. Nella malattia acuta non viene mai meno la speranza come apertura al futuro; mentre nella malattia cronica il futuro non è se non la ripetizione senza fine di un presente sempre uguale: al di là, talora, di ogni possibile speranza.”
Una sofferenza, quella dovuta alla malattia, che, in ogni caso, alimenta ininterrottamente la solitudine, che, a sua volta, si nutre altrettanto costantemente della sofferenza, precipitando l’interessato in un incessante circolo vizioso di angoscia e disperazione.
Nel testo, Eugenio Borgna ha integrato il suo discorso anche con alcune intense riflessioni di Romano Guardini riguardanti gli aspetti psicologici, umani e spirituali della solitudine, quale condizione imprescindibile della vita:
“La vita rimane sana solo quando continuamente rinnova l’esperienza della solitudine; in una certa misura ciò avviene in ognuno: in modo esemplare avviene in alcuni, a nome di tutti. Nella solitudine l’uomo inserito strettamente nella trama dei rapporti della comunità si desta alla consapevolezza della sua persona.”
La trascrizione delle riflessioni di Romano Guardini si è conclusa così:
“Questo inoltrarsi nella solitudine, nello spazio dell’‘io stesso con me stesso’, è dovere, e spesso assai pesante, poiché l’uomo viene qui in contatto con le potenze e le tensioni del suo intimo, con le esigenze incalzanti della sua coscienza.”
La solitudine, ha poi scritto Eugenio Borgna, è una “qualità” estrema e sempre viva nell’animo umano, sebbene non sia affatto semplice distinguerla dalla sua componente negativa, ovvero dalla solitudine-isolamento. L’autore l’ha definita a più riprese una condizione talora ineliminabile dalla vita, capace, a seconda dei casi, di riassumere in sé tanto il desiderio di riflessione e di contemplazione, quanto la tristezza, la sofferenza e l’angoscia. La solitudine, intesa come esperienza imprescindibile – almeno in alcuni momenti – dell’esistenza umana, è anche una metafora del silenzio, così come il silenzio può rappresentare una metafora della solitudine. Due dimensioni distinte e, al tempo stesso, intimamente e intrinsecamente collegate tra di loro.
L’infinito che vive dentro di noi, ha affermato nel testo l’autore, sopravvive soltanto se non ci lasciamo rapire e divorare dal “rumore” che arriva dall’esterno, ma, ancor peggio, se non ci lasciamo sopraffare nemmeno dal “frastuono” che talvolta agita anche la nostra vita interiore, magari lacerata da un dolore capace di offuscare tutte le nostre eventuali “stelle filanti”, qualsivoglia speranza. Questi “muri”, aggiunge l’autore, non sono affatto insormontabili, ragion per cui ci possono essere degli sconfinamenti reciproci. Ma, al tempo stesso, Eugenio Borgna si è chiesto come tentare, all’occorrenza, di indebolire e/o abbattere queste barriere e come confrontare le diverse manifestazioni della solitudine quando l’esistenza è ferita o, magari, è addirittura travolta da sentimenti quali la paura o l’angoscia. Al riguardo, l’autore ha precisato che la paura può emergere in esito a specifici eventi, mentre l’angoscia può manifestarsi anche senza apparenti nessi causali contingenti. Quest’ultima, arrivando talvolta inattesa e improvvisa, può far emergere scenari emotivi anche sconvolgenti. Non di meno, nel mondo di oggi, su piani non molto distanti da quelli dell’angoscia, possono insorgere incandescenti tensioni emotive tali da contaminare anche pesantemente – e talora in modo inatteso e fulmineo – le relazioni preesistenti. Si pensi, ad esempio, tra le tante paure che sembrano in grado di resistere e/o sfuggire al controllo razionale e alle possibili relative strategie curative di questa nostra moderna quanto fragile società liquida, al caso del virus denominato “SARS-CoV-2” (c.d. “Corona virus”, già precedentemente chiamato “2019-nCoV” o anche “Covid-19”). Ma anche a forme di paura più datate, quali quelle della diversità, dello straniero e, non ultima, a quella sempreverde ed inossidabile della follia.
L’esperienza della solitudine, in questi casi, emerge e si radica spietata, inevitabile, quanto dolorosa, amara e aggressiva. Tuttavia, secondo Eugenio Borgna, se la paura non è ormai scolpita indelebilmente nell’animo umano, se non ha sconfinato, divenendo una forma estrema e patologica di isolamento, è ancora possibile tentare di comprenderne le ragioni, talora infondate, è, quindi, provare in qualche modo a governarla, a (ri)orientarla, almeno in parte.
Nel testo, a queste riflessioni si aggiungono quelle di altre due peculiari emozioni umane, quali: la felicità e l’infelicità. Tanto radiosa e luminosa la prima quanto buia, insondabile e cupa la seconda. Ancor più nel caso di infelicità straziate e dolorose, talvolta finanche crudeli, connotate da forme di solitudine estreme, di insuperabile isolamento dal mondo, capaci di precipitare inesorabilmente nel silenzio la vittima di volta in volta interessata. Una solitudine, ha ricordato ancora una volta Eugenio Borgna, della quale non è comunque possibile fare a meno in alcuni momenti dell’esistenza umana, come testimoniano anche le opere letterarie e poetiche di autori della tradizione sia classica che contemporanea, tra i quali, solo per citarne alcuni in ordine sparso: Francesco Petrarca, Giacomo Leopardi, Friedrich Nietzsche, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke e Antonia Pazzi.
Poeti – o scrittori, aggiungo – comunque intesi da Paul Celan quali “ultimi custodi delle solitudini”, come ha evidenziato Eugenio Borgna citandolo.
Contributi, narrazioni, delle quali ha bisogno anche la psichiatria, allorché indaghi non la sola solitudine creatrice, aperta, trascendente, bensì le sue espressioni più sofferte, ovvero quelle psicotiche e autistiche. Esperienze con le quali la psichiatria ha a che fare quando si trova di fronte a forme di solitudine e di isolamento dolorose e involontarie, che imprigionano la persona interessata in antri oscuri, segnati da un egoismo e da un silenzio dolorosi, che soffrono anche la mancanza di un incontro e di un dialogo con l’altro da sé.
Una solitudine, ha ricordato Eugenio Borgna, che Rainer Maria Rilke ha descritto così:
“La solitudine è come una pioggia. Sale dal mare e va incontro alle sere; da pianure, lontane ed isolate, sale al cielo che sempre la possiede. E soltanto dal cielo cade sulla città. Piove quaggiù nelle ore indecise, quando verso il mattino si rivolge ogni vicolo, quando i corpi che nulla hanno trovato delusi e tristi si dividono; e quando quelli che s’odiano devono dormire nello stesso letto: poi la solitudine se ne va coi fiumi…”
Le riflessioni di Eugenio Borgna, andando oltre l’esplorazione della solitudine collegata con uno stato di malattia, non solo somatica, hanno intersecato anche le diverse possibili risonanze di piccole, ma sincere, forme di vicinanza e di immedesimazione. Si pensi, ad esempio, nel caso di ammalati ricoverati, al valore aggiunto anche di una sola parola autentica e, più in generale, alla scelta delle modalità più idonee di indagare, capire e curare al meglio le paure e le angosce che amplificano e lacerano l’animo di chi vive una dimensione di solitudine scatenata da una patologia severa.
Sempre in merito all’importanza delle parole, l’autore ha proposto nel suo saggio anche parte di una lettera di Marina Cvetaeva, una scrittrice russa affascinata dall’idea di una morte volontaria, nella quale, riguardo al “peso” delle parole, scriveva:
“La scelta delle parole è prima di tutto selezione e decantazione dei sentimenti: non tutti i sentimenti vanno bene – oh, credetemi, anche qui c’è bisogno di lavoro! Il lavoro sulla parola è lavoro su sé stessi.”
Queste riflessioni sottolineano una volta di più, nel caso ce ne fosse eventualmente ancora bisogno, quale importanza hanno dunque le parole, non solo in poesia, ovviamente. Quali risonanze emozionali possono creare in chi vive nell’angoscia, nel dolore, nella solitudine. Eugenio Borgna, citando Emmanuel Lévinas, ne ha fornito un altro interessante esempio, caratterizzato da una profondità vertiginosa e mostrando, al tempo stesso, l’inevitabile oscurità insita negli enigmi del linguaggio:
“Ogni parlare è enigma. Certo, si inserisce e si muove in un ordine di significati, comune agli interlocutori, in mezzo a verità trionfanti, cioè, prime, in una lingua che implica un sistema di verità note che, certo, per quanto banale, il parlare scuote e conduce a nuovi significati.”
Le parole, dunque, per “indicare”, quando possibile, nuovi orizzonti… di speranza. Soprattutto a chi è scivolato in una dimensione emotiva di estremo isolamento interiore, che può preludere alla fine di un’esistenza, anche volontaria, desiderata. Una dimensione che porta a confrontarsi con anime angosciate, disperate, affascinate dell’idea di una morte attesa e bramata. Una dimensione poliedrica che richiede all’interlocutore di decifrare, di intuire cosa si celi dietro il volto, ossia nell’intimo di chi soffre. Cosa eventualmente si nasconda nei gangli dolorosi di emozioni nascoste e segrete di tante anime che “urlano” nel silenzio, nell’isolamento, mentre stanno pensando concretamente al loro suicidio.
Sul linguaggio del corpo di chi soffre e vive uno stato di tristezza e di angoscia che ne segni, in particolare, il cuore e il volto, Eugenio Borgna ha chiamato in causa Rainer Maria Rilke, trascrivendone alcuni versi, che, in tema, si è era interrogato così:
“Volto, mio volto: di chi sei tu? Sei volto per quali cose? Come puoi essere volto per un Dentro così, dove perennemente l’iniziare col disciogliersi in qualcosa si addensa?”
Una dialettica che si inserisce nel quadro più ampio della contrapposizione tra la vita e la morte. Esperienze che sconfinano, sempre e comunque, l’una nell’altra. Morire, ha evidenziato Eugenio Borgna, è comunque ancora un modo di vivere, sebbene si tratti di un vivere residuo e, di norma, uno spirare corroso dall’angoscia e dalla disperazione, dallo smarrimento e dalla solitudine. E, alla fine di questo triste percorso, si muore, in ogni caso, soli. L’autore lo ha ricordato facendo ricorso alla parola alta e profetica di Georges Bernanos. La morte, ha aggiunto, è per antonomasia una sconosciuta della quale si sa con certezza che è il controcanto, la negazione vera, della vita. E il morire, ha sottolineato Eugenio Borgna, è il passaggio doloroso, quanto inevitabile, talvolta breve, talvolta no, dall’esistenza alla dissoluzione definitiva:
“L’ora, in cui si sta morendo, non è l’ora in cui si vive: nel vivere ad ogni ora segue un’altra ora, ad ogni istante un altro istante; e invece nel morire ogni ora può essere l’ultima: senza che abbia a venire dopo un’altra ora: un altro istante. Nel morire l’ora non ha più sorelle: nel naufragare di ogni possibile trascendenza nel futuro. Se la rimozione della morte sembra essere una caratteristica della coscienza occidentale, la rimozione del morire è esperienza molto più difficile da realizzare. Se tante persone del nostro tempo si preoccupano solo, o soprattutto, del morire (dei modi con cui si muore) e ricercano le vie che conducano ad un morire libero da angosce, ad un morire inavvertito e de-emozionalizzato, questo significa (anche) che non si vuole pensare alla morte nei suoi orizzonti di senso e di mistero. L’esperienza ultima della solitudine si ha, certo, quando si muore: quando si ha l’acuta, e straziante, coscienza che si è in cammino verso la morte, o almeno che alla morte ci si avvicina; e la solitudine del morente è immersa negli abissi del silenzio, e dell’indicibile. Oggi, sembra davvero che si guardi alla morte come ad un avvenimento indifferente ad ogni profonda significazione umana: come a qualcosa che si possa anticipare con grande leggerezza; solo preoccupandosi di evitare la sofferenza e l’angoscia che si accompagnano al venire-meno della vita. Il senso cifrato della morte, l’interrogazione radicale sul senso del vivere e del morire, della vita e della morte (sulla terrestrità, o sulla trascendenza, della morte), sembra divenire sempre più estraneo alla coscienza occidentale: bruciata, e divorata, dalla esigenza di fuggire dinanzi ad ogni problematica umana che non abbia soluzioni possibili.”
L’autore, mi sembra con coraggio, ha riflettuto a lungo su questo tema delicatissimo, richiamando anche le dolorose esperienze connesse con la morte della madre, come nel caso di Agostino e Roland Barthes e, come nel caso del già citato Georges Bernanos, della morte dello stesso protagonista. Una forma di solitudine terminale, il morire (da) soli, come, seppure in forme diverse, può essere altrettanto estrema ed insopportabile la sofferenza e la solitudine che si sperimentano anche nel caso della perdita di una persona particolarmente cara.
Ma queste forme di solitudine sono comunque differenti e/o talora anche molto distanti da quella di chi sceglie deliberatamente di mettere fine alla propria vita. Eugenio Borgna, al riguardo, ha ricordato che il morente vive sempre, per quanto breve, un’agonia. Chi sceglie di togliersi volontariamente la vita, evidenzia l’autore, spera invece di non agonizzare, non a lungo per lo meno. Per tale motivo, si è chiesto quindi Eugenio Borgna, quale potrebbe essere l’idea di libertà insita nell’opzione estrema del suicidio?
Ė forse questa, aggiungo?
Ed è anche percorrendo queste strade, dolenti e buie, ma, talvolta, ancora aperte alla speranza, che si svolto il discorso dell’autore sul linguaggio delle solitudini.
E, a proposito della speranza, Eugenio Borgna, ha proposto ancora una volta le parole di Emily Dickinson, che l’ha descritta così:
“È la “speranza” una creatura alata che si annida nell’anima – e canta melodie senza parole – senza smettere mai – E la senti dolcissima nel vento – e ben aspra dev’essere la tempesta che valga a spaventare il tenue uccello che tanti riscaldò – Nella landa più gelida l’ho udita – sui più remoti mari – ma nemmeno all’estremo del bisogno ha voluto una briciola – da me.”
Un cammino difficile, a tratti anche crudele e beffardo, quello sul linguaggio delle solitudini, percorso dall’autore, avendo ben in mente quanto ha scritto Franz Kafka:
“La vera via passa per una corda che non è tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo. Sembra destinata a far inciampare più che a essere percorsa.”
Un cammino aspro, dunque, talvolta percorso all’interno di un vero e proprio deserto emotivo, apparentemente privo di un senso qualsiasi, di un segno di speranza, come può accadere che ne faccia esperienza chi è vittima di una sindrome depressiva che prelude e/o accompagna un disegno suicida. In quella dimensione, il tema della morte, pur nell’enigmaticità e nell’assurdità del morire, aleggia e incombe particolarmente grave e imminente, quanto voluto, desiderato.
Richiamata nuovamente in causa dall’autore, Emily Dickinson, con i suoi versi, ha sintetizzato in modo emblematico l’enigmaticità delle diverse declinazioni della solitudine:
“Ha una sua solitudine lo spazio, solitudine il mare e solitudine la morte – eppure tutte queste son folla in confronto a quel punto più profondo, segretezza polare che è un’anima al cospetto di se stessa – infinità finita.”
Nel caso in cui non diviene isolamento, ha integrato Eugenio Borgna, la solitudine può invece divenire una dimensione portante dell’esistenza, aperta alla speranza e diretta verso il futuro. Una dimensione che con la solitudine-isolamento, con l’essere-soli straziato ed inchiodato da uno schiacciante e doloroso presente, ha – almeno apparentemente – comunque dei punti in comune con la solitudine creativa/costruttiva. Si pensi, ad esempio, alla distanza (non necessariamente fisica) dagli altri e al diradarsi/dissolversi (talvolta funzionale) dei rapporti interpersonali. Una dimensione positiva, comunque aperta, oltre che al colloquio interiore, sino alla trascendenza, anche all’altro da sé. Un percorso che aiuta la persona interessata ad uscire dalla propria individualità, portandola vero un altrove. In ogni caso ai confini dell’io, creando, in tal modo, i presupposti per un’incessante apertura verso l’altro. Un’apertura verso il mondo che l’autore ha ritrovato nei versi di Rainer Maria Rilke, il quale l’ha descritta così:
“E se torniamo a parlare della solitudine, si chiarisce sempre più che non è cosa che sia dato scegliere o lasciare. Noi siamo soli, soli di paura, nell’altro è l’unico appoggio, ogni parola sarà come un bosco su questo nostro cammino. La volontà è solo il vento che ci spinge, vortica e incalza, noi stessi siamo la nostalgia in fiore.”
La solitudine – compresa quella che si esprime sotto forma di isolamento è, comunque, anche un tempo interiore. E, riflettendo su questo tema altrettanto arcano e insondabile, l’autore ha proposto quello che sul tempo ha scritto Agostino, il quale, con parole tuttora di grande impatto, scriveva:
“Cos’è il tempo? Chi saprebbe spiegarlo in forma piana e breve? Chi saprebbe formarsene anche solo il concetto nella mente, per poi esprimerlo a parole? Eppure, quale parola più familiare e nota del tempo ritorna nelle nostre conversazioni? Quando siamo noi a parlarne, certo intendiamo, e intendiamo anche quando ne udiamo altri parlare. Cos’è dunque il tempo? Se nessuno m’interroga, lo so; se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so. Questo però posso dire con fiducia di sapere: senza nulla che passi non esisterebbe un tempo passato; senza nulla che venga, non esisterebbe un tempo futuro; senza nulla che esista, non esisterebbe un tempo presente […] Un fatto è ora limpido e chiaro: né futuro né passato esistono. È inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre: presente del passato, presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempo esistono in qualche modo nell’animo e non vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente è la visione, il presente del futuro l’attesa. Mi si permettano queste espressioni, e allora vedo ed ammetto tre tempi, e tre tempi ci sono”.
L’esperienza interiore del tempo, ha aggiunto quindi Eugenio Borgna è in relazione stretta con il tema e la realtà della solitudine e dell’isolamento. E, ancora in argomento, citando le riflessioni sul tempo di W.G. Sebald tratte dal suo romanzo intitolato “Austerlitz”, Eugenio Borgna ha trascritto queste intense riflessioni:
“Un orologio mi è sempre sembrato qualcosa di ridicolo, qualcosa di mendace per antonomasia, forse perché, per un impulso interiore a me stesso incomprensibile, mi sono sempre ribellato al potere del tempo escludendomi da cosiddetti eventi temporali, nella speranza […]che il tempo non passasse, non fosse passato, che mi si concedesse di risalirne in fretta il corso alle sue spalle, che là fosse come prima o, per meglio dire, che tutti i punti temporali potessero esistere simultaneamente gli uni accanto agli altri, cioè che nulla di quanto racconta la storia sia vero, che quanto è avvenuto non sia ancora avvenuto, ma stia appunto accadendo nell’istante in cui non ci pensiamo, il che naturalmente dischiude peraltro la desolante prospettiva di una miseria imperitura e di una sofferenza senza fine.”
Il passato, il presente e il futuro sono dunque incessantemente correlati, vicendevolmente segnati, senza che ne siano del tutto evidenti le ragioni. Così come non di rado sono tra loro indistinguibilmente legati e lacerati la memoria e la speranza, il passato e il futuro. In questa pluridimensionalità temporale, la solitudine di chi soffre, la fatica di vivere la vita da soli e/o con gli altri cresce drasticamente e pericolosamente. Nel dolore dell’anima si trasforma significativamente la nostra relazione con il mondo. Le parole che vengono rivolte a chi vive una forma di isolamento interiore non di rado appaiono lontane, fragili, senza echi e di poco o, addirittura, di nessuna sostanza e/o conforto. Una sua paziente, ha scritto l’autore, ha descritto così la profondità e la radicalità della propria sofferenza psichica:
“La sofferenza che ho è tremenda. Sono irrigidita nello sforzo di rimanere calma e di controllarmi. Il momento più tragico è il risveglio. Non vorrei mai addormentarmi per non avere questo risveglio. Mi sento imbevuta di sofferenza. Inumana. Una persona non dovrebbe potere soffrire così.”
Maria Teresa, questo il suo nome, straziata, proseguiva il suo sfogo scrivendo:
“Sono talmente invischiata in questo dolore che mi pare impossibile che possa togliermi questo peso dallo stomaco. Ci si sente come costretti a camminare su due gambe rotte. Mi sento tutta a pezzi. Si prova una sofferenza tremenda. Come ricercare qualcosa che non si raggiunge mai. Devo continuare a soffrire? Di che cosa è fatta questa sofferenza? Il dolore fisico, al confronto, non è niente. La musica mi procura una sofferenza acutissima probabilmente perché rievoca una sensazione di benessere e di serenità che ora non posso provare.”
Una sofferenza non solo fisica che, proseguendo, Maria Teresa ha descritto così:
“Mi sento il cuore in gola: come se avessi fatto una corsa. Vivere così mi sembra praticamente impossibile. Sono disperata. A me sembra di essere ancora prigioniera dell’angoscia e della disperazione. Mi sento colpevole nel non riuscire a superare questa situazione. Vivo come un automa.”
Una condizione persino assurda, che l’ha inoltre portata a dire:
“Non riesco a capire. Come è possibile che ci si venga a trovare in una situazione di vuoto così assoluto? Non è logico. Non succede niente se non che le cose sono sempre uguali. Mi sembra impossibile e incredibile di non stare ancora bene. Allora vuol dire che ho dimenticato come stavo prima: mi sembra che sia questo il massimo della sofferenza. Comunque è molto avvilente. Doversi affidare a una pastiglia, e basta. Ho una gran paura di essere abbandonata da tutti. Non ne posso più.”
Una sorta di prigione, dalla quale scriveva:
“Non riesco a liberarmi da questa angoscia. Sono esasperata da questa situazione. Non ne posso più. Mi sento ugualmente triste, ugualmente disperata. Ho paura di non guarire, e sto perdendo questa speranza. Devo continuare a soffrire? Di che cosa è fatta questa sofferenza? Il dolore fisico, le ripeto, non è niente al confronto. Tutti i contatti umani sono tragici. Mi sembra di essere diventata una pettegola: di diventare un’oca che si lamenta di tutto. Ho quasi paura di essere cambiata: questo lei lo esclude? Mi sento come prigioniera nelle sabbie mobili; e i tentativi per uscirne, sempre più blandi e disperati, raggiungono solo lo scopo di farmi precipitare più in fondo.”
Sino all’epilogo, sino alla dissoluzione, sintetizzata così:
“La disperazione s’impossessa di me perché mi accorgo di non potere contare sulla forza di volontà e di essere di conseguenza in balìa della mia angoscia. Non ce la faccio più a vivere così. Non riesco nemmeno a dirle che tipo di sofferenza sia: è qualcosa di quasi fisico. Razionalmente dovrei dire: non ho una ragione particolare per stare male; eppure sto male. È una situazione assurda. Una cosa disumana: non ne posso più. Questa sofferenza mi annulla.”
Questa paziente, ha sottolineato Eugenio Borgna, ha espresso in modo lucido, acuto e spietato la condizione di sofferenza e di dolore oscuro ed incomprensibile che le ha divorato l’anima. Un’emblematica rappresentazione di una straziante fenomenologia della sofferenza costellata da forme severe di angoscia e di disperazione. Un dolore dell’anima che, come già accennato, è in ogni caso una componente dell’esistenza, non necessariamente conseguenza di una patologia. Una possibile risposta, l’autore l’ha trovata nelle parole di Etty Hillesum, alimentate da un estremo ed irriducibile anelito di speranza che è sopravvissuto anche in un luogo di inaudita violenza come il campo di Westerbork (uno dei campi di reclusione e di transito durante la Seconda Guerra Mondiale):
“Se tutto questo dolore non allarga i nostri orizzonti e non ci rende più umani, liberandoci dalle piccolezze e dalle cose superflue di questa vita, è stato inutile.”
Un antidoto, anzi due, è dato dalla felicità e dalla gioia. In proposito, Eugenio Borgna ha ricordato che la felicità e la gioia sono, effettivamente, emozioni consanguinee, ma ognuna connotata da specificità proprie e da un orizzonte di senso proprio. Ne scriveva Rainer Maria Rilke, precisando che la felicità ha il suo contraltare emozionale nella infelicità. Controcanto che non ha, invece, la gioia, anche una gioia brevissima:
“La felicità irrompe sugli uomini, la felicità è destino; la gioia gli uomini la fanno fiorire dentro di sé, la gioia è semplicemente una buona stagione sopra il cuore; la gioia è la cosa massima che gli uomini abbiano in loro potere.”
Diversamente, Ludwig Wittgenstein ha condensato così la sua visione:
“Supposto che l’uomo non potesse esercitare la sua volontà, ma dovesse patire tutta la miseria di questo mondo, che cosa allora potrebbe renderlo felice? Come può l’uomo essere felice, se non può tener lontana la miseria di questo mondo? Mediante la via della conoscenza. La buona coscienza è la felicità procurata dalla vita di conoscenza. La vita di conoscenza è la vita, che è felice nonostante la miseria del mondo. Felice è solo la vita che può rinunziare ai piaceri del mondo. Per essa tutti i piaceri del mondo non sono che grazie del fato.”
Ancor più scarnificante e minimalista il pensiero di Friedrich Nietzsche, il quale ha delineato una sua forma di possibile redenzione della felicità umana:
“La felicità più piccola, purché esista ininterrottamente e renda felici, è senza confronto una felicità maggiore della più grande, che venga solo come episodio, per così dire come capriccio, come idea folle, fra mera sofferenza, brama e privazione.”
Un antidoto, in ogni caso, una risposta, si è detto, alle tante forme della solitudine, che, a seconda dei casi, può essere intesa come: destino, angoscia, senso di abbandono, disperazione. Come ha avuto modo di sperimentare, ha aggiunto l’autore, anche Madre Teresa di Calcutta.
Ma, in altri casi, la solitudine può invece intendersi anche come un’esperienza mistica, una trascendenza che ci può salvare, nel silenzio, dagli discorsi inutili del quotidiano e, più in generale, dall’insignificanza.
Senza dimenticare, ha sottolineato infine Eugenio Borgna, che di solitudine si può anche morire, come nel caso della solitudine della malattia. Precisando che le malattie più gravi non sono, comunque, sempre quelle somatiche, ma quelle che emergono dal dolore, dalla carenza di affetti, di amore e di amicizia, dalla povertà e dalla aridità del cuore.
Roma, 29 febbraio 2020
G. Regnani