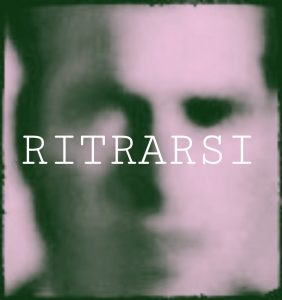“Ritrarsi“
La Fotografia e la Morte
Lo “spettro” della Fotografia
G. Regnani, s.t., 2020
Da sempre, nell’immaginario collettivo, la Fotografia sembra poter evocare sia l’idea della morte sia quella, opposta, di (un’effimera, quanto “infinita”) immortalità
a B.
di G. Regnani
gerardo.regnani@gmail.com
G. Regnani, s.t., 2020
Nel suo celebre “La camera chiara – Nota sulla Fotografia”, edito da Einaudi nel 1980, Roland Barthes ha descritto nel modo seguente una delle caratteristiche peculiari della Fotografia:
“Ciò che la Fotografia riproduce all’infinito ha avuto luogo una sola volta: essa ripete meccanicamente ciò che non potrà mai ripetersi esistenzialmente […] essa è il Particolare assoluto, la Contingenza suprema, spenta e ottusa, il Tale (la tale foto e non la Foto), in breve, la Tyche, l’Occasione, l’Incontro, il Reale.”
Percorrendo un binario affine, nel suo “Sulla Fotografia – Realtà e immagine nella nostra società”, edito da Einaudi nel 1978, Susan Sontag ha scritto:
“Ogni Fotografia è un memento mori. Fare una Fotografia significa partecipare della mortalità, della vulnerabilità e della mutabilità di un’altra persona o di un’altra cosa. Ed è proprio isolando un determinato momento e congelandolo che tutte le fotografie attestano l’inesorabile azione dissolvente del tempo.”
Ritrarsi o essere ritratto in una Fotografia ci immergerebbe, dunque, in una mini esperienza della Morte, in quanto, in tal modo, secondo Roland Barthes, si diventa un vero e proprio spettro. Al riguardo, ha anche annotato:
“Ciò che vedo è che io sono diventato Tutto-Immagine, vale a dire la Morte in persona”.
In proposito, ricordo che la parola immagine, [dal nominativo del lat. imago (-gĭnis)], è un termine che, come ricorda l’Enciclopedia Treccani, rinvia ad “uno schema immaginario, un prototipo inconscio che orienta in maniera specifica il modo in cui il soggetto percepisce l’altro.” Ne orienta, quindi, le relative proiezioni e “non va considerata come correlato di figure reali, ma presenta carattere fantasmatico.”
Scriveva ancora Roland Barthes:
“In ultima analisi, ciò che ho trovato estremamente affascinante sull’arte della Fotografia, e che mi affascina personalmente, è qualcosa che probabilmente ha un collegamento con la Morte. Forse questo è un interesse che si collega con la necrofilia, ad essere onesti, mi incanta ciò che è morto, ma è rappresentato come volontà di voler essere vivo”.
Roland Barthes ha anche evidenziato come la Morte “prenda forma” nella Fotografia, “assumendone” l’aspetto, attraverso la sua staticità, la sua freddezza e l’essere, in definitiva, una sorta di corpo senza vita. L’immagine fotografica fissando un dato istante ed interrompendo il flusso dinamico degli eventi, “si comporta” proprio come la Morte nei confronti della vita.
Si potrebbe quindi riassumere che, nella visione di questi due saggisti, così come nell’immaginario collettivo, la Fotografia, da sempre, rinvia all’idea della Morte.
Una relazione – o, forse, “la” relazione per antonomasia – che, partendo da un piccolo episodio privato (che lascerò tale) tenterò di tratteggiare ulteriormente attraverso le riflessioni che seguono.
Un’idea e una relazione, dunque, che – anche a causa dell’incessante sovrabbondanza di immagini che quotidianamente – e, non di rado, anche gratuitamente – ce la rappresentano ha portato (inevitabilmente e temibilmente) la Morte a diventare un evento come tanti altri possibili e, non di rado, uno spettacolo che non desta particolari emozioni. Quasi si dimenticasse, a tratti, l’assurda e irreparabile prevalenza della Morte sulla vita. Quasi si fosse ormai persa la consapevolezza della nostra ineluttabile fine biologica: “lo” stigma della nostra specie. Una tragedia che domina, condiziona e orienta da sempre le nostre vite. A partire dai gesti, dalle cose e dai materiali più semplici e comuni dei quali l’essere umano si serve ed è circondato sin dagli albori dei suoi insediamenti nella Preistoria. Si pensi, ad esempio, ad una materia comunissima come la pietra, che prima ancora che per la costruzione delle case, è stata probabilmente usata per creare delle sepolture. Un materiale che rappresenta tuttora, anche a livello simbolico, un baluardo esemplare per “combattere” e sfidare la caducità dell’esistenza. Una sfida contro l’inconoscibile rappresentato dalla Morte, esito inesorabile della finitezza biologica di qualsiasi essere vivente. Senza l’onnipervasività della Morte, senza questa eterna dittatura – drammatica ed incessante, al tempo stesso – molto verosimilmente non esisterebbe nulla di tutto quell’impianto di valori, di azioni e concezioni che ha segnato la storia dell’Umanità. Un insieme di segni, di liturgie, di riti funerari, di espressioni di lutto, etc., veicolati ed alimentati trasversalmente e significativamente anche dalla Fotografia. Fotografia, che, con il suo “grandangolo”, sin dal suo avvento, inquadra e documenta a tutto campo, tra l’altro, anche “le” nostre assenze. In particolare, la Morte ovvero l’Assenza assoluta, l’esito ineluttabile dell’intera vicenda umana, contribuendo alla costruzione dell’immaginario e della memoria collettiva. Un morire che, non di rado, tende ad essere culturalmente occultato, quasi che la sua eventuale negazione possa aiutarci a vivere meglio.
E la Fotografia, congelando apparentemente in ogni suo fotogramma l’attimo, il frangente, sembra fatta apposta per ricordarci proprio lo scorrere inarrestabile del tempo. Una facoltà documentaria che ogni fotografia condensa in sé essendo sostanzialmente un vero e proprio atto “politico”, ovvero una selezione formale di un frangente spaziale e temporale. Un gesto deliberato, dunque, volto ad isolare, anche in una prospettiva funzionale, una frazione del “reale”, in una forma atomica e circoscritta.
Tuttavia ogni fotografia, pur evocando la Morte, ne “contiene” apparentemente anche una sorta di antidoto. Per un verso, infatti, sembra interrompere lo scorrere del tempo e della vita, per un altro, rappresenta incessantemente un presidio contro la caducità dell’esistenza, salvando dall’oblio il particolare ritratto della “realtà” raffigurato e/o rappresentato in ogni ripresa.
Facendo un ipotetico parallelo con l’ambito medico, lo sguardo apparentemente “pietrificante” e letale della Medusa/Fotografia sembra idealmente condensare una sorta di morte biologica. Una dimensione caratterizzata dall’irreversibilità della cessazione delle funzioni vitali dell’organismo/soggetto interessato ovvero delle parti che lo compongono, allorché siano danneggiati in modo irreparabile. Una morte biologica diversa dalla c.d. morte clinica (o morte apparente), nella quale, invece, la sospensione delle funzioni vitali dell’organismo stesso non è necessariamente irreversibile, non essendo stato raggiunto un punto di non ritorno. In aggiunta allo sguardo fatale della Medusa – analogamente ad ogni altra raffigurazione, potremmo aggiungere – la Fotografia assomma anche la perenne ambivalente oscillazione tra una (presunta) verità e il suo opposto. La continua contrapposizione tra una (apparente) oggettività dell’automatismo dell’apparecchio e l’ineluttabilità della soggettività (dell’autore) in ogni sua espressione.
Una Fotografia dal “corpo” poliedrico e molteplice, dunque, in perenne e precario equilibrio tra il vero e il falso, tra un presente (per quanto differito) e il passato. E sempre in bilico tra la Vita e la Morte.
La Fotografia, nella sua poliedricità, rappresenta quindi uno dei baluardi più comuni e diffusi per salvaguardare il passato dall’oblio e tenerne una possibile traccia, ridando “una seconda vita” ad ogni attimo/frangente inesorabilmente scomparso. In altri termini, la Fotografia integra e talora sostituisce strategicamente la nostra stessa memoria.
In particolare, nei ritratti di una persona defunta, al pari di un dipinto, di una scultura, la Fotografia rappresenta la quintessenza di questa opera di salvaguardia della memoria, la custodia di un ricordo magari incerto di un’assenza. E la raffigurazione del soggetto ritratto può colmare o, almeno in parte, aiutare a gestire il senso di vuoto, di solitudine, talora persino di vertigine di fronte al nulla, al baratro che può essere causato da una scomparsa. La Fotografia può quindi divenire un presidio, una sorta di strumento magico – oltre che un ausilio per interpretare e riordinare il caos della realtà – in grado di dare nuova vita, di “resuscitare” in qualche modo il soggetto di volta in volta in essa ritratto. Cosi come la Fotografia/Morte, per un verso, interrompe ineluttabilmente il flusso dell’esistenza, viceversa, lo stesso medium, vestendo i panni della Fotografia/Vita, può invece farlo (metaforicamente) rinascere.
Riguardo al rapporto tra la Fotografia e la Morte, Roland Barthes ci ha dunque lasciato riflessioni che restano tuttora un punto di riferimento imprescindibile. A partire dall’atto stesso dell’essere ritratti o dell’autoritrarsi – ad es., attraverso il c.d. selfie dei giorni nostri – che trasforma in un oggetto il soggetto raffigurato. Lo rende (s)oggetto e insieme attore, come già accennato, di una microesperienza di morte e, in una prospettiva duale, anche di una rinascita. Conseguentemente, in questa prospettiva, qualsiasi fotografia diviene “vagamente spaventosa”, attestando, a suo modo, “il ritorno del morto”.
Un’esperienza attraverso la quale il soggetto tende a divenire idealmente uno spettro. Un fantasma che, in ogni caso, sopravvive alla Morte, rinascendo ad ogni sguardo.
Un evento, la Morte, che, in particolare nel mondo occidentale, è sovente ridotto a mero affare privato, considerato come un assurdo e spietato “inconveniente” finale dell’esistenza. Una follia, fonte di angoscia infinita e di un senso di solitudine, di impotenza e di frustrazione non di rado legati alla malattia e alla sofferenza. Una dimensione estrema che ha incessantemente ispirato anche la ricerca di tanti autori, stimolati dal comune sentirsi mortali, che, attraverso una ricerca personale, hanno cercato di trovare degli strumenti per tentare di affrontare o almeno di esorcizzare il timore, la paura della Morte e, insieme, il senso di effimero e di fragilità dell’esistenza.
Tra i tanti, citando, per brevità e per una certa vicinanza con i temi che mi interessano e restando prioritariamente nella sfera della Fotografia, ricordo i lavori di Joel Peter Witkin e Andres Serrano. Due famosi autori, entrambi, a loro modo, connotati da una ricerca che, per modalità ed espressione, richiama – più o meno esplicitamente – l’ambito della medicina legale (si pensi, in particolare, alla serie “The Morgue” realizzata nel 1992 da A. Serrano). I loro lavori, al di là dei possibili rimandi, sono comunque accomunati da una deliberata tendenza all’eccesso, alla provocazione estrema, alla dissacrazione. Fotografie che – per i contesti, per i soggetti e, non ultimo, per i volti, i corpi o le parti di questi ritratti senza alcun filtro nella loro terribile condizione – hanno riscosso tanta attenzione, così come hanno ricevuto non poche critiche. Le loro opere sono state finanche considerate delle (facili?) esche emotive per “fare colpo” su un diffuso quanto superficiale e patologico voyerismo morboso. Immagini criticate anche per la scelta dell’esplicito, dell’ostentazione del particolare talora particolarmente crudo, terrificante, raccapricciante, etc., piuttosto che sull’allusione, sul rinvio attraverso l’espediente del sottinteso. Una metodologia che ha portato alla creazione di opere nelle quali non di rado appare deliberatamente esasperata ed esaltata anche la diversità del soggetto ritratto. A partire da eventuali deformità fisiche, di tipo congenito e/o acquisite che siano, possibili devianze di natura psicologica e/o riconducibili alla sfera sessuale, etc. Una produzione d’autore che si distingue sia, “a monte”, per le correlate implicazioni etiche, filosofiche, religiose, etc., sia, “a valle”, per una estetica peculiare, universalmente riconoscibile, al pari di una specie di “marchio di fabbrica”. Opere singolari, dunque, insistentemente inclini a proporre soggetti, situazioni e scenografie tendenti a veicolare anche una sorta di culto dell’orrido, del deforme e, al tempo stesso, del vulnerabile e dell’effimero. Una teoria di raffigurazioni nelle quali viene riassunta ogni possibile forma di “miseria” umana, senza sconti per chicchessia. Vengono quindi apparentemente sdoganati e sembrano convivere in un contesto di apparente “normalità” il macabro, così come il morboso, l’atrocità, così come il disgustoso. La Vita e la Morte, proposte in un incessante e spaventoso vortice visivo.
Una produzione – estetica e di contenuti – che, inevitabilmente, appare non del tutto priva anche di possibili derive patologiche. Una condizione clinica che, plausibilmente, potrebbe essere rilevata quale tratto distintivo anche della produzione di altri autori più o meno ignoti, incluso lo scrivente, sebbene le mie immagini invitino l’osservatore ad avere uno sguardo che “attraversi” l’immagine, piuttosto che soffermarsi sulla sola superficie. Ciò non esclude, in ogni caso, l’individuazione di possibili tare patologiche anche per chi scrive. Una tara, tra altre possibili, nella quale forse si condensa buona parte, se non la totalità, dell’inquietudine umana sul tema della Morte.
G. Regnani, s.t., 2020
Un terrore primordiale, quello della perdita e della Morte, al quale, nel corso dei secoli, si è sempre tentato di reagire con diverse forme e strategie culturali. Tra queste, in età contemporanea, una popolare e diffusa modalità di rappresentazione dei defunti – favorita dall’avvento e dalla progressiva accessibilità e diffusione della Fotografia – è certamente stato il genere delle c.d. fotografie post-mortem e delle carte de visite. Una modalità di raffigurazione dei defunti, che ha vissuto un lungo e popolare periodo di utilizzo, a partire dall’epoca vittoriana fino al secondo dopoguerra, grazie anche all’opera di tanti anonimi fotografi.
Tornando a Roland Barthes e al suo “La camera chiara”, il semiologo francese, a proposito del rapporto che la Fotografia intrattiene da sempre con la Morte, ci ha evidenziato come in qualsiasi immagine di un volto, in particolare se l’attimo “congelato” nel ritratto riguarda una persona ormai scomparsa, si possa condensare un atto speciale, onnipotente, persino magico e, a tratti, persino trascendente. Una magia che, piuttosto che celebrarne la dissoluzione, sembra capace di “ridare la vita” all’immagine stessa e, indirettamente, alla persona scomparsa raffigurata in essa. Un simbolico dispositivo di riattivazione della Vita e della memoria, che, altrimenti, potrebbe dissolversi e scomparire una seconda volta anche nel nostro ricordo.
La Fotografia assume quindi anche la funzione di protesi affettiva e tecnologica della memoria, aiutandoci a ricordare, a rievocare qualcuno e/o qualcosa, che, talora inesorabilmente, con il tempo, potrebbe essere dimenticato. In quest’ottica, nell’immaginario collettivo, la Fotografia si conferma tuttora come uno dei più importanti – se non, addirittura, “il” medium privilegiato – per la conservazione della memoria e, quindi, della narrazione, non solo popolare, sia privata che universale.
Con la rappresentazione della scomparsa sembra dunque efficacemente sostanziarsi il rapporto privilegiato della Morte con la Fotografia. Un rapporto particolare che, emblematicamente, sembra poter paradossalmente emergere ed essere meglio testimoniato proprio da alcune tipologie di immagini fotografiche. Tra queste, ricordo quelle riconducibili alla c.d. cronaca nera. Immagini, che, dati i contenuti sovente particolarmente “sensibili” e la loro ormai abituale massiva circolazione, hanno sovente fatto emergere ben più di un interrogativo. Interrogativi che riguardano, ad esempio, l’opportunità o meno di realizzare in qualsiasi contesto delle fotografie non di rado particolarmente crude ed esplicite. E, andando “a monte”, interrogandosi anche sulle ragioni che, in nome dell’onnipresente diritto di cronaca, sembrano governare questa incessante “necessità” di rappresentare ed esibire sempre e comunque la Morte.
Non distanti dalle immagini di cronaca, ricordo ancora una volta anche quelle medico legali. Queste ultime – anche per taluni loro aspetti tecnici e/o funzionali – più e magari meglio di altre tipologie di fotografie sembrano in grado di affermare e confermare che la Morte è, ineluttabilmente, comuque la fine di tutto.
Al di là delle forme estetiche e della dialettica contingenti “raccontano” la fine dell’essere.
Senza poesia, senza sconti, senza speranza!
Un confronto sempre perdente, spietato, come avevo accennato già tempo fa.
G. Regnani, s.t., 2020
“Tutto è dotato di un’estetica e di una dialettica – tecnicamente, dei mezzi di comunicazione – persino quando queste proprietà sembrano assenti o, addirittura, negate.
Persino la Morte, sia vista in diretta sia mediata, comunque ne possiede.
L’angosciante sceneggiatura, è di norma caratterizzata da una successione di momenti agghiaccianti, non di rado contraddistinti da una surreale assenza apparente di dialettica.
La Morte, del resto, è una contingenza che non ammette – per statuto – alcuna contrapposizione dialettica con chicchessia.
È la dolente e immutabile negazione di qualsiasi confronto, senza pietà e/o sconti per nessuno.
Sempre implacabile di fronte a qualunque forma di vita.
Tutto, in ogni caso, dalla Morte in giù, comunque comunica anche attraverso espressioni estetiche e dialettiche – materiali, immateriali, mutevoli e peculiari che siano – anche qualora sembrino mancare e/o appaiano respinte al mittente.”
G. Regnani, s.t., 2020
Tornando al rapporto tra la Fotografia e la Morte, anche un comunissimo ritratto fotografico ne può rappresentare un esempio paradigmatico – ancor di più se si tratta della raffigurazione di un defunto – perché può apparire ancor più amplificato il suo o status di surrogato, di opzione di ripiego dell’immagine. Altrimenti detto, è una forma sostitutiva di una presenza ormai irrimediabilmente dispersa, che, in relazione anche agli elementi di contesto e con gradienti di efficacia variabile, sopperisce, come può, ad una assenza ormai irrimediabile. Questa condizione, questa sorta di “tara” di prodotto di seconda scelta, di rimpiazzo dell’originale, che accomuna la Fotografia alle altre rappresentazioni visive ci ricorda, come già accennavo, che essa, così come le sue (immagini) “cugine” condivide in ogni caso la perenne oscillazione tra la (presunta) verità e la (possibile) falsità immanente in ogni forma espressiva. Un “vacillamento” che comprende, dunque, anche quelle forme espressive come la Fotografia, solo in parte in qualche misura formalmente codificate, che la collocano più nella sfera più indeterminata del linguaggio, piuttosto che nell’ambito di un vero e proprio codice (ovvero di una “langue”). Un equilibrio precario, dunque, tra l’apparente oggettività – alimentata anche dal c.d. effetto di realtà che, di norma, contraddistingue le immagini fotografiche dalle altre raffigurazioni – e la connaturata emblematica connotazione di qualsiasi rappresentazione umana, ovvero la soggettività.
Pur con questi “difetti”, ci ha evidenziato Roland Barthes, la Fotografia continua ad affermare che un referente, da qualche parte, in un dato momento, comunque “è stato”. Nel caso del ritratto fotografico di una persona scomparsa questa qualità sembra ancor più evidente e peculiare, testimoniando anche l’assenza definitiva del protagonista dell’immagine stessa, oltre a quella legata allo scarto temporale tra la ripresa e la visione della ripresa. Elementi, questi, che, in ogni caso, ci possono comunque portare a preferire una fotografia proprio perché sappiamo che si tratta, appunto, proprio di una fotografia. E, in quanto tale, perché ci sembra in grado, più e forse anche meglio di altre forme di rappresentazione, di “fare le veci” della persona ritratta. In altri termini, di dare maggiormente giustizia al soggetto raffigurato.
Un esito legato ad un tempo che, come accennato, appare congelato, bloccato per sempre. Una sorta di effrazione temporale e di intrusione nella continuità del reale, quella prodotta dalla Fotografia. Una lacerazione potenzialmente in grado anche di alterare il passato, il presente e il futuro virtualmente condensati dentro l’immagine. In questo scenario, la Fotografia/Morte assume la connotazione di una frazione pietrificata del tempo che interrompe definitivamente ed in modo irreversibile la continuità della vita.
E lo sguardo immobile, congelato di ogni protagonista di un ritratto sembra emblematicamente ben riassumere tutto questo. Ancor di più, sottolineo ancora, nel caso in cui si tratti di una persona scomparsa. Ancor di più, allorché, anche inconsapevolmente, lo sguardo del protagonista punti dritto in macchina. In questo caso, per trasferimento, lo sguardo è già idealmente rivolto allo spettatore che – di volta in volta in un distinto momento futuro – osserverà poi l’immagine. Roland Barthes, in proposito, ci ha anche evidenziato che, seppure senza vederlo, nel momento dello scatto il protagonista ritratto nella fotografia “guarda” sin da subito il potenziale spettatore che lo vedrà poi ritratto nell’immagine (proiettando, da subito, astrattamente il proprio sguardo in una dimensione futura). Viceversa, lo spettatore potrà ricambiare” virtualmente dal futuro lo sguardo del protagonista originario – e, dunque, rivolgendosi idealmente verso il passato – osservandolo, inosservato, anche nel più assoluto anonimato. In questa duplice e asincrona relazione/prigionia, entrambi i soggetti appaiono indissolubilmente legati, seppure in una distinta e differente contingenza sia spaziale sia temporale.
Paradigmaticamente, in questo caso, l’immagine rappresenta un vero e proprio medium in grado di collegare – facendone le veci in una sorta di pluridimensione spazio/temporale e assicurandone la presenza “eterna” – la persona assente a suo tempo raffigurata nel ritratto. In altri termini, un particolare rapporto di interconnessione tra passato, presente e futuro e, insieme, di interrelazione differita tra il protagonista dell’immagine e lo sguardo dell’osservatore.
Ma non solo!
Perché, nel farlo, “testimonia” anche il ritrarsi della Fotografia stessa.
“La Fotografia si sottrae”, direbbe il semiologo francese per “lasciare spazio” al (s)oggetto ritratto nell’immagine. Un ritirarsi, un arretrare, per cedere la scena all’object trouvé visivo ritratto, all’attimo unico, alla Contingenza suprema, assoluta ed irriproducibile raffigurata nella Fotografia.
Per ribadirlo con le parole dello stesso studioso francese:
“Si direbbe che la Fotografia porti sempre il suo referente con sé, tutti e due contrassegnati dalla medesima immobilità amorosa e funebre, in seno al movimento; essi sono appiccicati l’uno all’altra.”
Per tali ragioni, di fronte ad un’immagine fotografica si osserva il (s)oggetto ritratto – e reso “al presente” – e non tanto la fotografia stessa.
Questo perché, ha ricordato in proposito Roland Barthes:
“una foto è sempre invisibile.”
Detto ciò, il semiologo francese ha indicato una qualità che, in ogni caso, deve essere comunque posseduta da una fotografia, ovvero la “forza documentativa”. Una proprietà che non riguarda tanto il (s)oggetto raffigurato nella fotografia quanto la relativa componente temporale. Al riguardo, Roland Barthes, ha anche sottolineato che:
“Da un punto di vista fenomenologico, nella Fotografia il potere di autentificazione supera il potere di raffigurazione.”
La Fotografia, quindi, oltre a “riprodurre” il reale, va oltre, ripresentandolo “al presente”, registrandone l’essenza visiva, sebbene differita a livello temporale. La Fotografia, in questa prospettiva, ci “parla” di qualcosa/qualcuno apparentemente all’oggi, sebbene venga da un momento passato. Il (s)oggetto ritratto, per quanto presentificato, resta comunque sempre presente soltanto “al passato”, ossia nel momento nel quale è stato di fronte all’obbiettivo.
In quest’ottica, ogni fotografia sembra poter raffigurare solo fantasmi.
Soltanto degli spettri.
E, non a caso, spectrum è proprio il termine usato dallo studioso francese per indicare il referente raffigurato in una fotografia.
Vista così, la Fotografia non sembra dunque “guardare” tanto in avanti – connotandosi, sostanzialmente, come un medium “senza futuro” – quanto al passato. Semmai, attraverso ogni nuovo sguardo, tenta insieme comunque anche di attualizzarsi. Restando comunque indissolubilmente unita al passato in una sorta di eterno legame/paralisi temporale.
Di fronte a questo sentore di passato – o di morte – l’osservatore può essere invaso da un senso di “macabro” e di mancamento di fronte al (s)oggetto raffigurato.
Un’entità, che, a livello temporale, è certamente già lontana, scomparsa, favorendo, ancora una volta, l’associazione della Fotografia all’idea della Morte.
Una “tara” presente in ogni ripresa, secondo il semiologo francese, che connota qualsiasi fotografia (indipendentemente, per quanto ovvio, dalla futura scomparsa biologica del protagonista dell’immagine).
Un eterno finto presente, dunque, immutabile e senza prospettive future, che fa apparire il referente come una specie di “cadavere” che ogni volta appare allo sguardo come uno spettro.
Una dimensione straniante, dove il “reale” è assente, ormai scomparso e sostituito da un simulacro visivo.
Una sorta di follia percettiva, una vera e propria allucinazione visiva che – attraverso questo medium folle – offre allo sguardo dello spettatore un referente di fatto oramai inesistente, che nell’immagine viene invece virtualmente reificato e reso presente “al passato”.
Roland Barthes ha quindi definito la Fotografia falsa sul piano percettivo, mostrando un (s)oggetto ormai perduto irrimediabilmente nel tempo passato, pur restando vera sul piano temporale.
“La Fotografia diventa allora per me un medium bizzarro, una nuova forma di allucinazione: falsa a livello della percezione, vera a livello del tempo.”
Questa dimensione oscillante tra una sorta di pseudoallucinazione e la schizofrenia, sembra amplificarsi ulteriormente nel caso di una persona scomparsa; ancor più se fotografata dopo il decesso. In tal caso, la Fotografia – pur non potendo restituire, per quanto ovvio, la vita biologica persa al defunto – sembra comunque poter offrire una illusoria, momentanea (succedanea) rinascita alternativa ogni volta che l’immagine viene mostrata/osservata.
In questa prospettiva, la Fotografia si conferma, quindi, come uno spaccato, un’interruzione nel continuum del reale che mostra sí un passato immodificabile, assoluto e ormai compiuto, ma, insieme, una potenziale, quanto solo ipotetica, occasione di “riscatto”, ovvero di rinascita, per quanto effimera e relegata solo ad una dimensione puramente immaginaria.
Una dimensione folle e allucinante che si nutre anche della capacità di ritrarsi della Fotografia a tutto vantaggio del referente raffigurato in essa. La Fotografia, ritraendosi, diviene dunque invisibile per mostrare e rendere “ancora vivo”, il proprio referente. E, arretrando, scompare come il referente stesso già a suo tempo scomparso, del quale, divenendo invisibile, ci mostra realmente soltanto quel effettivamente resta, ovvero una sorta di apparizione, un fantasma.
In sostanza, come accennavo, null’altro che uno spettro.
La Fotografia si connota, pertanto, come una specie di medium trasparente, attraverso il quale – non ci resta che – osservare “i resti” del referente originario.
Una fenomenologia che si alimenta anche dell’automatismo stesso della riproduzione. Una proprietà tipica della Fotografia che le consentirebbe di essere immune dalle “contaminazioni” della soggettività. Una qualità, la soggettività, che, secondo un diffuso credo comune, è più specifica dell’Arte, piuttosto che di un mezzo meccanico, automatico come la Fotografia. Una qualità che le permetterebbe di ambire ad un livello di oggettività tale da non temere più di tanto, per lo meno nel suo campo, possibili confronti. Una caratteristica che il semiologo francese ha riassunto così:
“Da un punto di vista fenomenologico, nella Fotografia il potere di autentificazione, supera il potere di raffigurazione.”
Qualità che, in una prospettiva meccanicistica, associano apparentemente l’immagine fotografica esclusivamente ad un automatismo, ovvero a quello che Roland Barthes ha definito una sorta di “messaggio senza codice”.
La Fotografia sembra quindi riproporci il referente originario senza mediazioni, senza filtri, apparentemente “incontaminato”, divenendo un mezzo e, insieme, anche un possibile documento per andare a ritroso nel tempo.
Uno sguardo mai terzo, però, aggiungo.
Sempre parziale, sempre affetto da possibili, quanto talora anche inconsapevoli, “conflitti d’interesse” dell’autore che estrapola l’immagine da un contesto specifico. Così facendo, “piega” la Fotografia alle sue intenzioni/esigenze di senso. A partire dalla cornice reale o virtuale dell’immagine stessa e creando, in ogni caso, uno scollamento, una distanza, uno iato, tra il referente ritratto e il senso che – talora persino inconsapevolmente accennavo e non solo dall’autore – gli viene poi di volta in volta “incollato” dentro/addosso.
Non propriamente, verrebbe da dire, un messaggio senza codice. Quanto, piuttosto, una vera e propria scelta politica, condensata nell’azione dell’autore, che, di fatto, oltre alla fotografia, fa ritrarre e, quindi, svanire anche l’idea stessa di un’immagine intesa come un innocente contenitore trasparente.
Il nostro sguardo, in sostanza, non attraversa la superficie della Fotografia come se fosse una parete di vetro trasparente, bensì attraversa qualcosa di ben più “denso”. Come, ad esempio, il contingente strato di senso – che, per quanto denso non sempre risulta ben visibile – di caso in caso “spalmato” (talora anche inconsapevolmente, ripeto) sull/nell’immagine.
Un “addomesticamento” di senso realizzato per creare se non proprio una lettura puntuale e/o analiticamente predefinita dell’immagine, per lo meno un perimetro interpretativo più o meno circoscritto.
Guardare – o eventualmente riguardare – una fotografia che raffigura qualcuno, ancor di più se si tratta di una persona ormai scomparsa e a noi particolarmente cara, può verosimilmente innescare/significare tutto questo.
Tutt’altro, dunque, che un semplice e (apparentemente) innocente e trasparente “messaggio senza codice“.
Roma, 2 novembre 2020
G. Regnani
G. Regnani, s.t., 2020
* * *
Riferimenti
Barthes Roland, L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Einaudi, Torino, 1985;
Id., La camera chiara. Nota sulla fotografia, Einaudi, Torino ,1980;
Davide Bordini, Immagine e oggetto – La camera chiara di Roland Barthes e il realismo fotografico;
Benjamin Walter, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Einaudi, Torino, 1966;
Marra Claudio, Le idee della fotografia. La riflessione teorica dagli anni sessanta a oggi, Bruno Mondadori, Milano, 2001;
Sontag Susan, Sulla fotografia – Realtà e immagine nella nostra società, Einaudi, Torino, 1978.
gerardo.regnani@gmail.com
English version*
RITRARSI
The “Specter” of Photography
G. Regnani, s.t., 2020
Throughout collective imagination, Photography seems to evoke both the idea of death and its opposite, the (ephemeral yet “infinite”) immortality. In his renowned work “Camera Lucida – Reflections on Photography,” published by Einaudi in 1980, Roland Barthes described one of the distinctive characteristics of Photography as follows: “What the Photograph reproduces to infinity has occurred only once: the Photograph mechanically repeats what could never be repeated existentially […] it is the absolute Particular, the supreme Contingency, faded and dull, the Such (that specific photo and not the Photo), in short, the Tyche, the Occasion, the Encounter, the Real.” Along a similar line, in her book “On Photography,” published by Einaudi in 1978, Susan Sontag wrote: “Every Photograph is a memento mori. To take a photograph is to participate in another person’s (or thing’s) mortality, vulnerability, mutability. Precisely by slicing out this moment and freezing it, all photographs testify to time’s relentless melt.” To be photographed or to photograph oneself would, therefore, immerse us in a mini experience of Death, as Roland Barthes suggests, turning us into true specters. He noted: “What I see is that I have become All-Image, that is, Death in person.” In this context, the term “image” [from the Latin nominative imago (-gĭnis)] refers, as the Treccani Encyclopedia reminds us, to an “imaginary scheme, an unconscious prototype that specifically guides the way the subject perceives the other.” It guides the subject’s projections and “should not be considered as correlated with real figures, but rather presents a phantasmic character.”
Barthes further wrote: “Ultimately, what I found extremely fascinating about the art of Photography, and what personally fascinates me, is something that probably has a connection to Death. Perhaps this is an interest connected to necrophilia, to be honest, I am enchanted by what is dead, but it is represented as the desire to want to be alive.” Barthes also highlighted how Death “takes shape” in Photography, assuming its appearance through its stillness, coldness, and being, ultimately, a kind of lifeless body. The photographic image, by capturing a specific moment and interrupting the dynamic flow of events, “behaves” just like Death does toward life. It could be summarized that, according to these two essayists’ views as well as in the collective imagination, Photography has always been associated with the idea of Death. A relationship—or perhaps “the” relationship par excellence—that, stemming from a small private episode (which I will leave as is), I will further outline through the following reflections. An idea and a relationship that, due to the incessant overflow of images in our daily lives—often free of charge—have inevitably and alarmingly led Death to become an event like many others, and not infrequently, a spectacle that doesn’t arouse strong emotions. It’s as if, at times, the absurd and irreparable prevalence of Death over life were forgotten. As if the awareness of our inescapable biological end—the stigma of our species—had been lost. A tragedy that has always dominated, influenced, and directed our lives. Starting from the simplest and most common gestures, things, and materials that humans have used and have been surrounded by since the dawn of their settlements in Prehistory. Consider, for example, the common material of stone, which, even before being used for constructing homes, was likely used to create burials. A material that still symbolically represents a exemplary stronghold to “fight” against and defy the transience of existence. A challenge against the unknowable represented by Death, the inevitable outcome of the biological finitude of any living being.
G. Regnani, s.t., 2020
Without the omnipresence of Death, without this dramatic and incessant dictatorship, there likely would be nothing of the system of values, actions, and conceptions that has marked the history of Humanity. A collection of signs, liturgies, funeral rites, expressions of mourning, etc., that are transversally and significantly conveyed and fueled, also by Photography. Photography, with its “wide angle,” has framed and documented comprehensively since its inception, capturing, among other things, “our” absences. In particular, Death, or absolute Absence, the inevitable outcome of the human experience, contributes to constructing the collective imagination and memory. Death, which often tends to be culturally hidden, as if its denial could help us live better. And Photography, apparently freezing every moment in its frames, seems made to remind us of the inexorable passage of time. A documentary faculty that each photograph encapsulates, essentially being a genuine “political” act, a formal selection of a spatial and temporal moment. A deliberate gesture aimed at isolating, even functionally, a fraction of the “real,” in an atomic and circumscribed form. However, every photograph, while evoking Death, also apparently “contains” a kind of antidote. On the one hand, it seems to halt the flow of time and life; on the other hand, it constantly acts as a defense against the ephemeral nature of existence, preserving the particular portrait of “reality” depicted or represented in each shot from oblivion. Drawing a hypothetical parallel with the medical field, the seemingly “petrifying” and lethal gaze of the Medusa/Photograph ideally condenses a kind of biological death. A dimension characterized by the irreversibility of the cessation of the vital functions of the organism/subject or its constituent parts when they are irreparably damaged. This biological death is distinct from clinical death (or apparent death), in which the suspension of the organism’s vital functions isn’t necessarily irreversible, as a point of no return hasn’t been reached.
In addition to the fatal gaze of the Medusa, Photography—similarly to any other representation—also encompasses the perpetual ambivalent oscillation between (presumed) truth and its opposite. The ongoing juxtaposition of (apparent) objectivity from the automatic nature of the apparatus and the inevitability of subjectivity (of the author) in all its expressions. A multifaceted and multi-dimensional Photography, constantly teetering between truth and falsehood, between a (deferred) present and the past, and always in balance between Life and Death. Thus, in its versatility, Photography is one of the most common and widespread tools for preserving the past from oblivion, leaving a possible trace and “breathing new life” into every moment or fragment that has vanished. In other words, Photography strategically integrates and sometimes substitutes our own memory. Particularly in portraits of deceased individuals, like paintings or sculptures, Photography represents the quintessence of this memory-preserving endeavor, the safeguarding of a possibly uncertain remembrance of an absence. The depiction of the subject in the photograph can help fill or at least partially manage the sense of emptiness, loneliness, and sometimes even vertigo in the face of nothingness, the abyss brought about by someone’s passing. Photography can thus become a safeguard, a kind of magical tool—besides being a means to interpret and rearrange the chaos of reality—that can somehow “resurrect” the subject depicted in it. Just as Photography/Death, on one hand, inexorably interrupts the flow of existence, on the other hand, when taking on the role of Photography/Life, it can metaphorically give it (re)birth. Regarding the relationship between Photography and Death, Roland Barthes left us with reflections that still remain an essential reference point. Starting with the act of being portrayed or self-portraying—e.g., through today’s “selfies”—which turns the depicted subject into an object. It renders them (s)ubject and at the same time an actor, as mentioned earlier, in a microexperience of death and, dually, of rebirth. Consequently, from this perspective, any photograph becomes “vaguely frightening,” attesting, in its own way, to “the return of the dead.” An experience through which the subject ideally becomes a specter. A phantom that, in any case, outlives Death, being reborn with every gaze. An event, Death, which, particularly in the Western world, is often reduced to a private matter, considered as a ludicrous and ruthless final “inconvenience” of existence. A madness, a source of infinite anguish and a feeling of loneliness, powerlessness, and frustration often linked to illness and suffering. An extreme dimension that has continually inspired authors, driven by the common experience of mortality, who, through personal exploration, have sought tools to confront or at least exorcise the fear of Death and, along with it, the sense of ephemerality and fragility of existence.
G. Regnani, s.t., 2020
Among many, citing for brevity and due to a certain affinity with the themes of interest, I recall the works of Joel Peter Witkin and Andres Serrano. These two famous authors, each in their own way, characterized by an approach that, in mode and expression, calls to mind—the medical-legal field (consider, in particular, A. Serrano’s 1992 series “The Morgue”). Their works, beyond possible references, are united by a deliberate tendency toward excess, extreme provocation, and desecration. Photographs that—due to the contexts, subjects, and, not least, the faces, bodies, or parts of these portraits—have garnered significant attention and have not been devoid of criticism. Their works have even been considered (easy?) emotional bait to impress a widespread yet shallow and morbid voyeurism. The images have been criticized for choosing explicitness, showcasing the particularly raw, terrifying, gruesome aspects rather than implying or alluding through subtlety. A method that has led to the creation of works where the diversity of the subject depicted is deliberately exaggerated and enhanced. This includes physical deformities, whether congenital or acquired, possible psychological deviations or those related to sexuality, etc. A distinctive production method that is not without potential pathological tendencies. A clinical condition that plausibly could also be detected as a distinctive feature of the work of other more or less unknown authors, including myself, although my images encourage the viewer to have a gaze that “penetrates” the image rather than focusing solely on the surface. This, however, doesn’t exclude the possibility of identifying potential pathological traits in the writer as well. One such flaw, among others, in which perhaps a significant part, if not all, of the human anxiety about Death is condensed. The primal fear of loss and Death, to which, over the centuries, people have always tried to react with various cultural forms and strategies. Among these, in the contemporary age, a popular and widespread mode of representing the deceased—fueled by the advent and increasing accessibility and dissemination of Photography—was undoubtedly the genre of post-mortem photographs and carte de visite. This mode of depicting the deceased, which saw a long and popular period of use from the Victorian era to the post-World War II period, was facilitated by the work of numerous anonymous photographers.
G. Regnani, s.t., 2020
Returning to Roland Barthes and his “Camera Lucida,” the French semiotician highlighted how, in any image of a face, especially when the “frozen” moment in the portrait concerns someone who has passed away, a special, all-powerful, even magical, and at times transcendental act can be condensed. A magic that, rather than celebrating dissolution, seems capable of “reviving” the image itself and, indirectly, the person depicted within it. A symbolic device for reactivating Life and memory that could otherwise dissolve and vanish a second time in our recollection. Thus, Photography also assumes the role of an affective and technological prosthesis of memory, aiding us in remembering, evoking someone or something that could otherwise, over time, be forgotten. From this perspective, in the collective imagination, Photography continues to be one of the most important—if not, indeed, the privileged—mediums for preserving memory and, consequently, narrative, both private and universal. The representation of absence effectively materializes the privileged relationship between Death and Photography.
A particular relationship that emblematically seems to paradoxically emerge and be better attested by certain types of photographic images. Among these, I recall those related to so-called “black news” or crime news. Images that, given their often particularly “sensitive” content and their habitual massive circulation, have frequently raised more than one question. Questions that concern, for example, the appropriateness or not of producing, in any context, photographs that are often particularly raw and explicit. And, going back to the source, questioning the reasons that, in the name of the omnipresent right to news, seem to govern this incessant “need” to represent and exhibit Death always and everywhere. Not far from news images, I also recall forensic photographs. The latter, even due to certain technical and/or functional aspects, more than perhaps other types of photographs, seem to assert and confirm that Death is inevitably the end of everything. Beyond aesthetic forms and contingent dialectics, they “narrate” the end of being. Without poetry, without concessions, without hope! A consistently losing, ruthless confrontation, as I mentioned some time ago. “Everything possesses an aesthetics and a dialectic—technically, communication means—even when these properties seem absent or even denied. Even Death, whether seen directly or mediated, possesses them. The distressing script is usually characterized by a succession of chilling moments, often marked by a surreal apparent absence of dialectic. Death, after all, is a contingency that does not admit—by statute—any dialectical opposition with anyone. It is the painful and unchanging negation of any confrontation, mercilessly and without mercy for anyone. Always relentless in the face of any form of life. Everything, in any case, from Death downwards, communicates through aesthetic and dialectical expressions—whether material, immaterial, mutable, or peculiar they may be—even if they seem to be missing and/or appear rejected by the sender.”
Returning to the relationship between Photography and Death, even a common portrait photograph can represent a paradigmatic example of this—a deceased person’s portrait even more so—because its status as a surrogate, a fallback option for the image, can appear amplified. In other words, it becomes a substitute for a presence irreparably dispersed, which, in relation to contextual elements and with gradients of varying effectiveness, makes up for an irreparable absence as best as it can. This condition, this sort of “defect” of a second-choice product, a replacement for the original, which unites Photography with other visual representations, reminds us, as I mentioned, that it, along with its (image) “cousins,” always shares the perpetual oscillation between the (presumed) truth and the (possible) immanence of falsehood in every form of expression. A “wavering” that thus includes expressive forms like Photography, only partially codified in some formal measure, which place it more in the indeterminate sphere of language, rather than within a true code (that is, a “langue”). A precarious balance, then, between apparent objectivity—also fueled by the so-called reality effect that typically distinguishes photographic images from other depictions—and the inherent emblematic connotation of any human representation, namely subjectivity. Despite these “flaws,” Roland Barthes pointed out to us, Photography continues to affirm that a referent, somewhere, at a given moment, “was.” In the case of a photographic portrait of a deceased person, this quality seems even more evident and unique, also testifying to the definitive absence of the image’s protagonist, in addition to the absence linked to the time gap between the capture and the viewing of the capture. Elements that, in any case, can lead us to prefer a photograph precisely because we know that it is indeed a photograph. And, as such, because it seems capable, more and perhaps even better than other forms of representation, of “standing in” for the depicted person. In other words, of doing greater justice to the portrayed subject. An outcome linked to a time that, as mentioned, appears frozen, forever halted. A kind of temporal intrusion and intrusion into the continuity of reality, one produced by Photography. A potential laceration capable of altering the past, the present, and the future virtually condensed within the image. In this scenario, Photography/Death takes on the connotation of a petrified fraction of time that definitively and irreversibly interrupts the continuity of life. And the still, frozen gaze of each protagonist in a portrait emblematically seems to encapsulate all this. Even more so, I emphasize, in the case of a deceased person; even more so when, perhaps unknowingly, the gaze of the original protagonist is directed straight into the camera. In this case, by transference, the gaze is already ideally directed at the viewer who—each time at a different future moment—will then observe the image. In this dual and asynchronous relationship/captivity, both subjects appear indissolubly linked, albeit in a distinct and different spatial and temporal contingency. Paradigmatically, in this case, the image represents a true medium capable of connecting—theoretically placing it in a multidimensional space/time and ensuring its “eternal” presence—the absent person depicted in the portrait. In other words, a particular relationship of interconnection between the past, present, and future, and, at the same time, a deferred interrelation between the subject of the image and the viewer’s gaze. But not only that! In doing so, it also “testifies” to Photography’s withdrawal. “Photography withdraws,” the French semiologist would say, “to make room” for the subject depicted in the image. A withdrawing, a stepping back, to give way to the visual object found in the image, to the unique moment, to the supreme, absolute, and unrepeatable Contingency depicted in the Photography. To reiterate it in the words of the same French scholar: “It could be said that Photography always carries its referent with it, both marked by the same amorous and funeral immobility, within movement; they are stuck to each other.” For these reasons, in front of a photographic image, one observes the portrayed subject—and rendered “in the present”—and not so much the photograph itself. This is because, as Roland Barthes reminded us in this regard, “a photograph is always invisible.” That said, the French semiologist indicated a quality that, in any case, must still be possessed by a photograph, namely “documentary power.” A property that concerns not so much the subject depicted in the photograph as the temporal component. In this regard, Roland Barthes also emphasized that: “From a phenomenological point of view, in Photography, the power of authentication exceeds the power of representation.” Therefore, Photography, in addition to “reproducing” reality, goes beyond it, representing it “in the present,” registering its visual essence, albeit deferred in terms of time. In this perspective, Photography “speaks” to us of something/someone seemingly at present, though coming from a past moment. The portrayed subject, though made present, always remains only “in the past,” that is, in the moment when they stood before the lens. From this viewpoint, every photograph seems to be able to depict only ghosts. Only specters. And not by chance, “spectrum” is precisely the term used by the French scholar to indicate the referent depicted in a photograph. Seen in this way, Photography doesn’t seem to “look” so much forward—essentially marking itself as a medium “without a future”—as it does to the past. Rather, through each new gaze, it also tries to become current. Remaining, however, indissolubly tied to the past in a kind of eternal temporal bond/paralysis. In the face of this sense of the past—or of death— the observer can be overcome by a sense of the “macabre” and of loss in the face of the portrayed subject. An entity, which, temporally, is certainly already distant, disappeared, favoring, once again, the association of Photography with the idea of Death. A “defect” present in every shot, according to the French semiologist, which characterizes any photograph (regardless, of course, of the future biological disappearance of the subject of the image). An eternal false present, therefore, unchanging and without future prospects, making the referent appear like a kind of “cadaver” that each time appears to the gaze as a specter. A estranging dimension, where the “real” is absent, now disappeared and replaced by a visual simulacrum. A kind of perceptual madness, a true visual hallucination which—through this mad medium—offers the gaze of the viewer a referent that is effectively now non-existent, but is instead virtually reified and made present “in the past” within the image. Roland Barthes thus defined Photography as false on a perceptual level, showing an (s)ubject irrevocably lost in the past time, while remaining true on a temporal level. “Photography then becomes for me a strange medium, a new form of hallucination: false at the level of perception, true at the level of time.” This oscillating dimension between a kind of pseudo-hallucination and schizophrenia seems to be further amplified in the case of a deceased person, even more so if photographed after death. In such a case, Photography—although it cannot restore, of course, the lost biological life to the deceased—still seems to offer an illusory, momentary (substitute) alternative rebirth every time the image is shown/observed. In this perspective, Photography confirms itself as a glimpse, an interruption in the continuum of reality that shows, yes, an unalterable, absolute, and completed past, but also a potential, though purely hypothetical, opportunity for “redemption,” or rebirth, however ephemeral and confined to a purely imaginary dimension. A mad and hallucinatory dimension that is also fueled by Photography’s ability to withdraw, to the advantage of the depicted referent within it. Photography, in withdrawing, thus becomes invisible to show and make “still alive,” its referent. And by stepping back, it disappears just like the referent itself that had disappeared in its own time, of which, becoming invisible, it actually only shows us what really remains, namely a sort of apparition, a ghost. Essentially, as I mentioned, nothing more than a specter. Photography is thus characterized as a kind of transparent medium through which we can only observe “the remains” of the original referent. A phenomenology that is also fed by the very automatism of reproduction. A characteristic of Photography that would allow it to be immune from the “contaminations” of subjectivity. A quality, subjectivity, which, according to a widespread common belief, is more specific to Art than to a mechanical, automatic medium like Photography. A quality that would allow Photography to aspire to a level of objectivity that doesn’t fear, at least within its realm, possible comparisons. A characteristic that the French semiologist summarized as follows: “From a phenomenological point of view, in Photography, the power of authentication exceeds the power of representation.” A quality that, in a mechanistic perspective, seemingly exclusively associates the photographic image with automatism, that is, what Roland Barthes defined as a kind of “message without a code.” Photography thus seems to present to us the original referent without mediation, without filters, seemingly “uncontaminated,” becoming both a means and, at the same time, also a possible document to go back in time. However, not exactly a third-party perspective, I would add. Always partial, always affected by possible, sometimes unconscious, “conflicts of interest” of the author who extracts the image from a specific context. In doing so, they “shape” Photography according to their intentions/needs of meaning. Starting from the real or virtual frame of the image itself and creating, in any case, a detachment, a distance, a gap between the depicted referent and the meaning that—sometimes even inadvertently hinted at, not only by the author—then gets “glued” onto it. Not precisely, one might say, a message without a code. Rather, a veritable political choice, condensed in the author’s action, who, in fact, beyond photography, makes the image portray and thus vanish the very idea of an image understood as an innocent transparent container. Our gaze, essentially, does not pass through the surface of Photography as if it were a pane of transparent glass, but passes through something much denser. Like, for example, the contingent layer of meaning—which, as dense as it may be, is not always clearly visible—case by case “spread” (sometimes even unconsciously, I repeat) onto the image. A domestication of meaning carried out to create, if not a precise and/or analytically predetermined reading of the image, at least a more or less circumscribed interpretive perimeter. Looking—or possibly looking again—at a photograph that portrays someone, even more so if it is a person who has now passed away and is particularly dear to us, can plausibly trigger/signify all of this. Quite different, therefore, from a simple and (apparently) innocent and transparent “message without a code.”
by Gerardo Regnani
INDICE POST
https://gerardo-regnani.myblog.it/
HOMEPAGE WEBSITE
https://www.gerardoregnani.it/
(*) Translation by ChatGPT Open AI